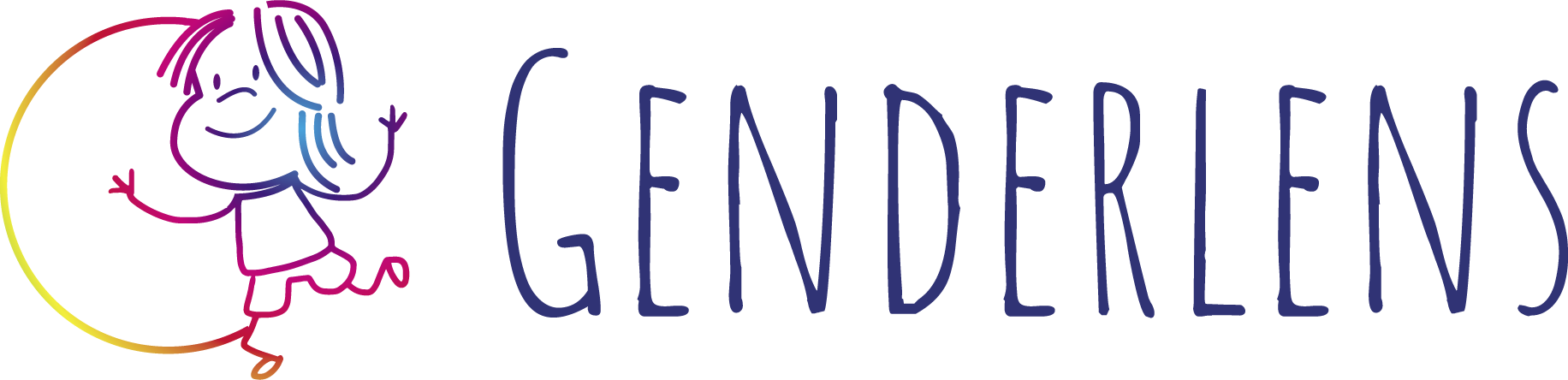Valeria Roberti, tra le altre cose, è autrice di Fuori dai binari, uscito da pochi mesi per Settenove, una casa editrice che, come riportano sul sito, “nasce nel 2013 ed è il primo progetto editoriale italiano interamente dedicato alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere,” ma che in realtà è molto di più. Per questo vi invito a esplorare il loro catalogo (e chissà che magari non passeranno anche loro da queste parti).
Dopo una delle presentazioni del libro che ha fatto con Giulia Selmi e Caterina Di Loreto ho chiesto a Valeria di poter parlare del libro e del suo lavoro.
Ciao Valeria. Ti va di presentarti alle persone che seguono Genderlens?
Ciao, Sono una formatrice, autrice e attivista. Mi sono avvicinata all’attivismo per la comunità Lgbtqia+ prima dei vent’anni e ho iniziato a svolgere attività formative sulle questioni di genere e della prevenzione del bullismo nel 2006 per poi dedicarmi, negli ultimi dieci anni, alla formazione del personale educativo collaborando con diverse realtà associative.
Partiamo con un paio di domande facili facili. Cosa vuol dire non binario?
Per fortuna che era una domanda facile! Non binario è una definizione di identità di genere che esce dal binarismo, maschio – femmina, a cui siamo abituate. E questo dovrebbe poterci bastare. Tutto il resto, tutte le considerazioni, le domande aggiuntive di chi non riesce a prendere questa come risposta, sono portatrici di stereotipi di genere che ci vengono dati per colazione dalla nascita ed è per questo che dire “fuori dal binario maschio femmina” crea spaesamento.
Come e perché è nato questo libro?
Dopo la pubblicazione di Una scuola arcobaleno, di cui sono coautrice con Giulia Selmi, che aveva lo scopo di dare una panoramica sulle soggettività lgbtqia+ a scuola, ho iniziato a chiedermi come dare maggiore visibilità a quelle soggettività che restano ai margini, ovvero le persone non binarie e trans. Monica Martinelli, editrice di Settenove, ha accolto con interesse le mie riflessioni e mi ha spinta a scrivere Fuori dai binari, con l’obiettivo di fare chiarezza sui termini, le sfide, le necessità di giovani e giovanissime persone che vivono al di là del binarismo di genere.
Che cos’è un approccio queer a scuola?
Per me avere un approccio queer a scuola significa mettere in discussione il potere e il privilegio che ogni figura educativa ha nel momento in cui entra in classe e si relaziona con studenti di ogni età. Questo è il punto cruciale: chi sono? cosa porto di me in classe? come comunico, che parole uso, come mi rivolgo alla classe?
Tutte domande fondamentali che dovrebbero guidare chiunque, al di là della presenza, o meno, di persone non binarie, trans o gender variant nel proprio ambiente educativo.
Come fare a superare le resistenze presenti nella scuola? Mi sembra, da fuori, che sia l’ostacolo più grande siano più le famiglie + movimenti politici conservatori.
Mi sembra chiaro che, fuori dalla scuola, ci sia proprio un gioco di potere che strumentalizza l’infanzia.
Alla base c’è sempre la distanza tra la struttura-istituzione e come viene vissuta/declinata/usata dalle singole persone, da come viene approcciato il discorso della struttura, anche gerarchica, con le implicazioni del potere.
La scuola deve essere un luogo di crescita libero e aperto ma le dinamiche di potere, come già affermi tu, influenzano molte scelte a tutti i livelli, dalla dimensione classe, alla dimensione istituto, fino alla dimensione nazionale e direttive del ministero. Non possiamo pensare di combattere tutto questo in un’unica volta perché è troppo… ma dobbiamo difendere la libertà della scuola, l’importanza di essere un ambiente indipendente, in cui il corpo docente ha spazio per insegnare le materie e per attivare processi di crescita personale di ogni singola persona, in base alle proprie attitudini e peculiarità. Le famiglie, alcune famiglie, sembrano non poter accettare che la scuola affronti temi ritenuti scomodi, come l’educazione alla sessualità, ma questo atteggiamento non paga perché se una persona piccola o giovane vuole saperne di più su un certo argomento troverà altri modi per farlo e sappiamo bene come internet e i social possano essere forieri di informazioni ma anche di fake news e situazioni inadeguate allo scopo di educare.
Credi che per risolvere i conflitti interni, per esempio casi di bullismo o omolesbobitransfobia si possano usare strumenti diversi dal punitivismo disciplinare? Si possono usare altri approcci alla giustizia che stanno emergendo fuori dalla scuola?
Assolutamente! Non ho mai pensato che “la punizione” potesse portare ad una modifica sostanziale dei comportamenti di chi agisce con fare discriminatorio. Certo, è importante far sapere che alcuni comportamenti non possono essere tollerati proprio perché discriminatori ma oltre ad uno stop posto ad un’azione sbagliata è importante lavorare con la classe, con chi ha compiuto l’azione, per poter attivare un cambiamento significativo sul lungo periodo.
Essere una persona LGBTQIA+ significa anche vivere in un’eterna adolescenza o meglio, il discorso è rivolto ad adolescenti anche adulti. intendo adolescenza come un momento di cambiamento. Da questo punto di vista credo che la rappresentazione mediatica sia importante perché in un momento di passaggio è essenziale poter vedere, leggere, altre storie (anche se un po’ si assomigliano tutte).
La rappresentazione mediatica è sempre stata importante, ora ci sono più media a cui guardare e ognuno ha le sue peculiarità e il suo “ritmo” con cui sta, più o meno, dietro a ciò che accade nella società. Nel libro cito un elenco di persone importanti (dal mondo dello spettacolo, dello sport, dei fumetti, dell’accademia, ecc) che si sono definite non binarie perché credo sia fondamentale dare la possibilità a chi è in cambiamento di trovare dei modelli di riferimento. Che poi possono anche venir messi in discussione o stravolti, ma che servono quando si naviga nel mondo delle domande. Per me la queerness è avere sempre 19 anni, non più adolescenza, non ancora età adulta. E in questo, potersi fare compagnia con persone “uguali” è molto rilevante! Poi, è vero anche che le storie si somigliano tutte… ma ci sono quei momenti nella vita in cui ci si vuole sentire dire certe parole precise.
Al centro della questione didattica forse non direttamente poni la questione della relazione, che è un concetto e una pratica femminista. E la relazione tra docente e discente implica anche un investimento emotivo da parte di tutte le persone in gioco. Solo che si dovrebbe avere anche una certa intelligenza e maturità emotiva, che per forza di cose, chi sta dietro ai banchi è probabile che non abbia. Non credo che l’educazione emotiva, prima ancora di quella affettiva e sessuale, possa essere solo una responsabilità della famiglia.
Non sono convinta che le persone più giovani siano deboli in fatto di intelligenza emotiva, provo a spiegarmi. Credo che non vengano accompagnatə a leggere le proprie emozioni, a nominarle, a gestirle e questa è una pratica che andrebbe favorita dalla tenera età perché è la chiave di una serie di comportamenti più consapevoli e rispettosi. Le persone piccole imparano da tutto ciò che sta loro attorno: se le figure adulte (famiglie o insegnanti) non sono in grado di gestire, nominare, trasformare l’emotività e anzi, sfruttano atteggiamenti denigratori, offensivi per relazionarsi con chi sta loro intorno, è evidente che le persone giovani faranno fatica a uscire da quello schema comportamentale. Credo invece che l’ascolto, la relazione, la disponibilità reciproca possono fare molto, proprio per ribadire che siamo sullo stesso piano, quando si tratta di educazione, è un rapporto a più direzioni.
Legato al discorso precedente, cioè il soggetto politico docente, c’entra anche il discorso del precariato. Come si fa a voler una scuola oggettiva quando chi insegna viene messx in una situazione spiacevole?
Questo è un altro aspetto molto impattante del sistema scolastico: chi insegna dovrebbe poter avere tutti gli strumenti a sua disposizione per lavorare con serenità e ragionevole dedizione. Tu citi il precariato, potremmo anche parlare della difficoltà che numerose figure educative LGBTQIA+ hanno nel fare coming out, per tanti e validi motivi. Sicuramente il ruolo di docente, educatore/trice, insegnante oggi non è tra i più semplici da ricoprire proprio perché l’aspetto politico sembra essere lo spauracchio da cui prendere le distanze, come se chi ha rivestito il ruolo dell’insegnante non avesse avuto, nel tempo, un ruolo politico. Ciò che posso aggiungere, come fosse un invito, è di fare rete: so che non è per niente facile ma trovo che sia una delle poche, forse l’unica vera strategia che potrebbe darci l’agio di portare dei cambiamenti radicali, anche se inseriti tra le pieghe di un sistema con molti difetti.
Le differenze di cui tenere conto non riguardano solo il genere, il binarismo, i pronomi e tutte cose, ma anche vari tipi di disabilità, tutti i tipi di disabilità, persone che non hanno l’italiano come madrelingua (e dire che le lingue non romanze potrebbero anche aiutare nel trovare nuovi modi per gestire il linguaggio di genere).
Da una parte certe differenze ci sono sempre state, dall’altra stanno cambiando molte cose proprio nella società, ed è abbastanza idiota avere un atteggiamento che faccia finta che non stia succedendo.
Le differenze di classe poi si acuiscono con la scelta delle superiori, tra le scuole della classe media e alta e le altre.
Come si fa a gestire tutto questo senza poter riformare la scuola da capo?
Ah! Sarebbe bello riformare la scuola da capo!
Qui, secondo me, il ruolo di docenti capaci di ascoltare al di là delle interrogazioni è fondamentale. Almeno, per me lo è stato, e credo di non essere l’unica ad aver trovato lo spazio sicuro per raccontarmi, raccontare le mie ambizioni e desideri a qualcunə che, non solo non era della famiglia stretta, ma anche aveva un ruolo educativo, riuscendo a diventare una figura di riferimento, di confronto, di accompagnamento durante gli anni della scuola. Oltre a questo, che rischia di essere attuato solo grazie alla buona volontà di chi insegna, credo che dovremmo rivedere alcune modalità di approccio, anche dei percorsi didattici stessi: come già osservi ci sono così tante variabili che a forza di creare il percorso adatto ad ogni diversità ci ritroviamo con troppe frammentazioni… forse basterebbe fare un passo indietro e semplificare alcune cose?
Negli ultimi anni, trovo il discorso delle etichette e delle definizioni quasi un discorso nozionistico. Nella pretesa che si debba conoscere tutto il vocabolario/formulario corretto per parlare di identità ed esperienze LGBTQIA+. Credo anche che sia una reazione a decenni di ignoranza e superficialità.
Anche vero che come dicevamo prima, in determinati momenti della vita rappresentazioni non dico corrette, ma oneste e trasparenti, e le definizioni identitarie sono necessarie. Cosa ne pensi?
Questo è un tema molto rilevante oggi, a maggior ragione visto che le giovani generazioni viaggiano a velocità diverse dal mondo adulto. Credo che il discorso si possa svolgere su due piani: da un lato c’è il bisogno di chi non conosce le parole, ad impararle, saperle usare, dare una posizione a un concetto astratto. In questo caso le definizioni non devono essere gabbie e chi, “dall’esterno” vuole conoscere deve imparare che ogni definizione di sé non può che essere in movimento. Questo significa ad esempio che non esiste un solo modo di essere non binary e va messo in conto.
L’altro piano è il piano di autoaffermazione che va di pari passo con la visibilità. Se mi do un nome, se rientro in una categoria esisto. E’ riduttivo, limitante, statico ma in alcuni momenti della vita, per alcune persone più che per altre, questo passaggio è fondamentale. Non tutte le esperienze sono uguali e non è sensato costringere nessuno a definirsi (con parole che già esistono) ma deve essere garantita la libertà di poterlo fare in maniera trasparente con sé e con il mondo che ci circonda.